Perché alcuni tradizionalisti sbagliano strada.
di Don Mario Proietti (16 luglio 2025)
C’è un’ombra che si allunga su alcune frange del tradizionalismo cattolico. Non si tratta semplicemente di amore per la bellezza liturgica o per l’ortodossia; al contrario, questo è lodevole e necessario. Ma quando la Tradizione viene assolutizzata fino a diventare un’ideologia, allora qualcosa si spezza. Stiamo assistendo, in alcuni ambienti, a una vera mutazione spirituale, dove una luce falsa e accecante prende il posto della vera luce della Tradizione viva. Ed è una questione seria, che merita la nostra attenzione e preghiera.
Una domanda apparentemente semplice ha riacceso di recente un dibattito che rivela dinamiche profonde: “È peccato non andare al Novus Ordo Missae?”. Le risposte che ne sono scaturite mostrano come, in alcune frange del tradizionalismo, stia emergendo non solo un problema dottrinale, ma una deformazione spirituale che va riconosciuta per essere curata. Vediamo nel dettaglio le dinamiche interiori, a tratti “patologiche”, che si sono manifestate proprio in questo episodio.
1. La sostituzione del sensus Ecclesiae con il sensus sui. Il primo segnale è quando il discernimento non avviene più “con” la Chiesa, ma “al posto” della Chiesa. Il criterio di giudizio diventa interamente personale: “ciò che io percepisco come giusto è la verità”. Nel dibattito, un commentatore ha affermato: “Non ci stava bisogno di un altro [Messale], nell’atto di voler sostituire, scimmiottando quanto avvenne poi nel 1570, il Messale della Messa di sempre, con tante e tali alterazioni MAI accadute prima”.
Si arriva così ad accusare la Chiesa di aver introdotto un rito contrario alla volontà di Dio, negando cinquant’anni di approvazione pontificia e magisteriale. Questo è un pensiero pericoloso: se la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, potesse ingannare universalmente i suoi figli nel culto e nella liturgia, allora non sarebbe più la Chiesa fondata da Cristo. In questa logica, ogni discernimento ecclesiale viene subordinato all’opinione individuale. Non si accetta più un’autorità esterna, perché si ritiene che la propria sensibilità sia il metro ultimo della Tradizione. È il principio della disgregazione: dove ognuno è Chiesa a sé, la Chiesa non è più una. La conseguenza più grave? Che la fede si privatizza e il Vangelo diventa un pretesto per contestare tutto ciò che non ci somiglia.
2. La trasformazione dello zelo in ideologia. Lo zelo autentico è sempre intriso di carità e trema nel parlare della Sposa di Cristo. Ma in certe derive, il linguaggio si fa duro, tagliente, quasi violento. Nel nostro scambio si sono lette espressioni come: “cena protestante”, “ripetitore degli eretici teologi d’oltralpe”. La liturgia, il luogo più sacro della comunione con Dio, viene trattata come un campo di battaglia ideologico. Si pretende di difendere la verità, ma senza amore, e si finisce per colpire il Corpo di Cristo. Come ho scritto in risposta: “la forza dello zelo rischia di essere sporcata da un giudizio troppo duro”.
Ma un amore che colpisce non è amore. E una verità senza carità non viene da Dio. San Paolo, parlando degli zelanti senza discernimento, scrive: “Hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza” (Rm 10,2). Lo zelo ideologico non cerca di convertire se stessi a Cristo, ma di convertire la Chiesa alla propria visione. È una guerra combattuta nel nome della Croce ma senza portarla nel cuore.
3. La proiezione del dolore personale sulla teologia. Dietro certe accuse si nasconde spesso un dolore reale e legittimo: liturgie svilite, catechesi inconsistenti, pastori assenti. Ma invece di guarire attraverso il perdono e il ritorno alla verità, quel dolore viene trasformato in criterio dottrinale universale. Affermazioni come “hanno smesso di insegnare la Messa di sempre nei seminari diocesani” o “la Messa riformata ha qualche validità solo perché deriva da quella di San Pio V” rivelano un trauma non elaborato, che si tramuta in accusa generalizzata. La sofferenza, per quanto profonda, viene scambiata per verità assoluta.
Quante volte si ascoltano anime sinceramente ferite: “Mi hanno tolto tutto”, “Mi hanno cambiato la Messa”, “Mi sento orfano nella mia parrocchia”. È vero, in molti casi c’è stato uno sradicamento. Ma non si può trasformare quel trauma in dottrina universale. Se il dolore non viene elaborato e sanato, si trasmette solo rabbia e risentimento. Chi non ha fatto pace con la propria ferita, difficilmente può essere un custode sereno della Tradizione; ne diventa invece un proiettore distorto.
4. Il rifiuto della Croce presente. Quando si rifiuta il volto della Chiesa umiliata, ferita, confusa nel presente, si finisce per voler Cristo Re senza Cristo Crocifisso. Ho provato a richiamare a una visione soprannaturale della storia, scrivendo: “la permissione divina non è segno di abbandono, ma di purificazione”. Ma la risposta è stata chiarissima: “se si parla del Messale di Paolo VI come permissione, allora sì, è come l’azione degli spiriti maligni”. Questo equiparare la liturgia riformata a un castigo demoniaco è l’esatto contrario di una fede pasquale, che accetta il mistero del kenosis e della Passione.
Chi crede davvero nella Risurrezione non teme il volto sfigurato della Chiesa. La riconosce come Cristo nel Getsemani, nel Pretorio, sulla Croce. Non la rinneghiamo solo perché non ha più l’aspetto che ci aspettavamo o che desidereremmo. La vera Tradizione passa sempre per il Golgota e si rinnova attraverso di esso.
5. Il delirio da élite. “Solo noi abbiamo capito”, “solo la nostra Messa è vera”, “gli altri sono sviati”. Questo atteggiamento, anche se chi lo porta avanti recita ancora il Credo, genera uno scisma del cuore. Si finge di non mettere in discussione il papato, ma si disconosce di fatto ogni suo atto e ogni suo pronunciamento non conforme alla propria visione. La vera Tradizione, invece, non isola, non separa, non crea partiti. È un legame di comunione, non di esclusione.
La superbia spirituale è la più difficile da riconoscere: si veste da fedeltà e si nutre di verità parziali, ma produce solitudine, rancore e divisione. È come chi costruisce un altare perfetto, ma poi vi sacrifica l’unità e la comunione ecclesiale.
Cosa fare, allora?
Di fronte a queste dinamiche, il compito dei fedeli e dei pastori è chiaro. Le interazioni come quella descritta mostrano la necessità di:
Continuare a parlare con chiarezza, ma senza polemiche. La mia risposta pubblica ha cercato di fare proprio questo: correggere con rispetto, spiegare con fermezza, senza alzare il tono, ma con l’intento di illuminare e unire.
Rimanere nella Chiesa, amandola anche quando non ci capisce o non ci somiglia. Amarla anche quando soffre. Amarla anche quando sbaglia nei suoi membri. Perché la Chiesa resta santa in Cristo, nonostante le ferite e i limiti dei suoi figli.
Vivere la Tradizione come dono, non come reazione. La Tradizione non nasce da un rifiuto del presente, ma da una fedeltà profonda al deposito della fede. È memoria viva, non nostalgia sterile o polemica. È fonte di unità, non pretesto di separazione.
E soprattutto, pregare per chi è stato ferito. Pregare per chi giudica. Pregare per chi resiste alla Croce della Chiesa di oggi. Solo l’azione dello Spirito Santo può sciogliere i cuori induriti e ricondurre alla piena comunione.
Lo diceva il beato John Henry Newman, con parole che oggi suonano profetiche: «Molti uomini hanno costruito la loro fede sulla Tradizione senza mai passare per la Croce. Ma chi ha visto la Croce, non può più odiare la Chiesa.»
Questa è la vera via: non la fuga dalla sofferenza della Chiesa, ma l’abbraccio della sua Croce, che sola può guarire le ferite e ricondurre alla vera luce della Tradizione.
La Messa, anche quella riformata, è sempre lo stesso Sacrificio di Cristo, e la sua legittimità deriva dall’approvazione della Chiesa stessa, non dalla nostra personale valutazione.
(fonte)
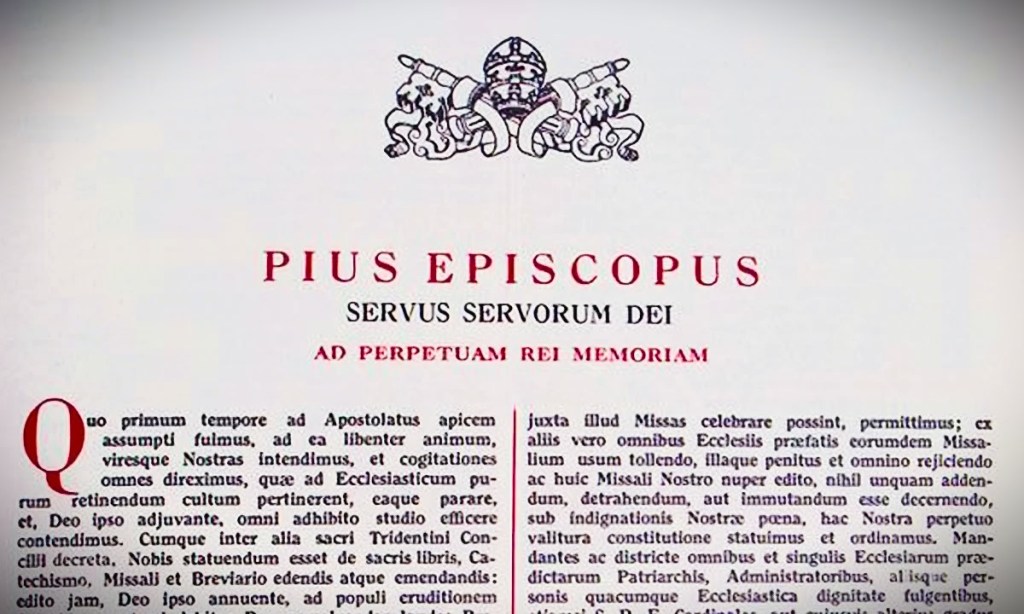
I PRESUNTI “VINCOLI PERPETUI” DEL MESSALE DI SAN PIO V: CHIAREZZA STORICA E VERITÀ CATTOLICA
di Don Mario Proietti cpps del 23 luglio 20205
Nei commenti alle riflessioni che condivido sulla liturgia e sulla vita della Chiesa, ricorre spesso una contestazione: «Ma il Messale di San Pio V non poteva essere cambiato, perché San Pio V lo ha vincolato in perpetuo!». Questa obiezione viene avanzata soprattutto da chi vede nel Messale di Paolo VI una rottura rispetto alla Tradizione e cerca nella Quo Primum la prova che la riforma liturgica non sia legittima. È una questione delicata, che merita di essere chiarita con serenità, senza pregiudizi e senza slogan, alla luce della storia e della dottrina cattolica.
Che cosa significano, dunque, quelle parole solenni di San Pio V, «da valere in perpetuo», «nulla mai possa venir aggiunto, detratto, cambiato», che leggiamo nella Costituzione Quo Primum del 1570? Sono esse il sigillo di un dogma immutabile, che lega per sempre la Chiesa al Messale tridentino, oppure esprimono una norma disciplinare, riformabile secondo le leggi della Chiesa? È su questo punto che occorre fare chiarezza, distinguendo con precisione tra ciò che è immutabile perché appartiene alla fede e ciò che, pur venerabile, rimane nell’ordine della disciplina.
Perpetuo, nel linguaggio canonico del XVI secolo, non significava affatto immutabile per sempre, ma stabile fino a nuova disposizione della suprema autorità. Il Papa, infatti, è legislatore supremo e nessuna norma disciplinare può sottrarre ai suoi successori la pienezza di potere che Cristo stesso ha conferito al Romano Pontefice. Non esiste nella Chiesa cattolica la possibilità che un Papa vincoli in modo irrevocabile l’autorità dei futuri Papi in materia di riti, cerimonie e rubriche. Se San Pio V avesse voluto proclamare un dogma, avrebbe impiegato la forma propria delle definizioni infallibili, cosa che non avviene nella Quo Primum, la quale rimane un atto legislativo, non una dichiarazione dogmatica.
Del resto, la storia è maestra. Se le parole di San Pio V avessero introdotto un vincolo assoluto, come mai, già pochi decenni dopo, Clemente VIII e Urbano VIII modificarono il Messale? Come spiegare le riforme di San Pio X, che intervenne sulla distribuzione dei Salmi e sul calendario, o quelle di Pio XII, che trasformò la Settimana Santa? Eppure nessuno gridò all’abuso o all’invalidità, perché era chiaro a tutti che le rubriche sono materia di legge ecclesiastica e la legge, per sua natura, è mutabile. La clausola che vieta di aggiungere o togliere non era rivolta ai Pontefici, ma ai vescovi e ai sacerdoti, per impedire che ciascuno introducesse innovazioni arbitrarie, alterando l’unità del rito. La suprema autorità, invece, rimane intatta e viva, sempre capace di intervenire per il bene della Chiesa.
Cosa rimane, allora, immutabile? Non il formulario di un Messale, ma la verità che esso custodisce e manifesta: il sacrificio eucaristico come vero sacrificio propiziatorio, in cui Cristo si offre al Padre per i vivi e per i defunti, rendendo presente in modo incruento il sacrificio della Croce. Questo è il dogma definito dal Concilio di Trento, che proclama: «Se qualcuno dirà che nella Messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, sia anatema»; e ancora: «Se qualcuno dirà che il sacrificio della Messa è solo commemorazione e non propiziatorio, sia anatema». Ecco i vincoli eterni: non le rubriche, ma la sostanza. E qui non si discute: nessun Papa, nessun Concilio, nessuna epoca potrà mai negare questa verità senza uscire dalla fede cattolica.
Quando si invoca la Quo Primum come se fosse un dogma intangibile, si cade in un errore duplice: si confonde il livello disciplinare con quello dogmatico e si finisce per negare, di fatto, la suprema potestà pontificia, come se San Pio V avesse potuto limitare i suoi successori in ciò che Cristo non ha voluto limitare. Una contraddizione insanabile. Se prendessimo alla lettera questa tesi, dovremmo accusare di illegittimità tutti i Pontefici che, dopo Pio V, hanno ritoccato il Messale romano, ma nessuno teologo serio lo ha mai fatto, perché conosce la dottrina e conosce la storia.
Non è, dunque, in discussione la santità e la bellezza della liturgia tridentina, che la Chiesa riconosce come tesoro prezioso; è in gioco la verità sulla natura delle leggi ecclesiastiche e sulla loro differenza rispetto ai dogmi. L’immutabilità riguarda la fede, non le rubriche; riguarda il sacrificio di Cristo, non la disposizione dei testi. Ogni Papa, nella continuità della Tradizione, ha il dovere e il diritto di provvedere all’ordine liturgico, perché la liturgia è viva, non fossilizzata, e vive per condurre le anime a Dio nella fedeltà sostanziale al mistero.
Chi vuole ridurre la questione a un cavillo giuridico o a una bandiera ideologica tradisce lo spirito stesso del Concilio di Trento e della Quo Primum, che nacquero per custodire la purezza della fede, non per creare una gabbia in cui imprigionare la potestà della Chiesa. La vera perpetuità non è quella di una legge, ma quella della fede che la legge serve. Ed è questa la fede che dobbiamo difendere: la Messa è sacrificio, è propiziazione, è memoriale vivo della Pasqua di Cristo. Questo non cambierà mai, perché appartiene all’essenza della nostra religione, non alle contingenze delle forme liturgiche.

